 I paesi occidentali hanno creato economie floride perché si sono dotati di istituzioni inclusive. Ma devono impedire che le élites acquisiscano eccessivo potere. Se le élites diventano dominanti, possono condizionare le istituzioni e determinare il declino dell’economia. Ne sono convinti gli economisti Daron Acemoglu e James A. Robinson nel libro Why Nations Fail, che molti considerano già una pietra miliare nella storia dell’economia politica.
I paesi occidentali hanno creato economie floride perché si sono dotati di istituzioni inclusive. Ma devono impedire che le élites acquisiscano eccessivo potere. Se le élites diventano dominanti, possono condizionare le istituzioni e determinare il declino dell’economia. Ne sono convinti gli economisti Daron Acemoglu e James A. Robinson nel libro Why Nations Fail, che molti considerano già una pietra miliare nella storia dell’economia politica.
Perché gli Stati Uniti sono più ricchi del Messico? E perché alcuni paesi falliscono mentre altri imboccano la strada dello sviluppo e della ricchezza? È la domanda delle domande, la stessa a cui Adam Smith cercò di rispondere nel 1776 quando pubblicò La Ricchezza delle Nazioni, e che oggi ci poniamo quando vediamo la Grecia che affonda, l’Italia che imbarca acqua e la Germania che va avanti come una portaerei nei mari in tempesta. Per sciogliere questo interrogativo Daron Acemoglu (economista del Mit) e James A. Robinson (Harvard) hanno pubblicato un libro (Why Nations Fail, Random House) che molti economisti già considerano una pietra miliare nella storia dell’economia politica. Anche perché i due economisti non si limitano a formulare una teoria. Fanno un passo in più: la applicano formulando una previsione che ha il sapore dell’eresia: la travolgente avanzata della Cina, secondo loro, è destinata a entrare in crisi se il colosso asiatico non affronterà radicali riforme istituzionali.
Ma cominciamo dall’inizio. Acemoglu e Robinson sostengono che sono le istituzioni a determinare il destino delle nazioni: un paese fiorisce quando le istituzioni sono “inclusive” e pluralistiche, cioè quando i diritti di proprietà sono garantiti, i livelli di partenza uguali per tutti, l’iniziativa individuale incoraggiata. Al contrario, le nazioni falliscono quando le istituzioni sono “estrattive” ed elitarie, cioè quando «sono strutturate per estrarre risorse da molti per distribuirle a pochi, i diritti di proprietà non vengono protetti e gli incentivi per l’attività economica sono insufficienti». In parole povere: la storia insegna che la ricchezza di un paese cresce se i cittadini sono incentivati a innovare e a investire; al contrario, i paesi si impoveriscono se le istituzioni disincentivano i singoli individui e proteggono piccole aree di privilegio.
Per avere un’idea della complessità e delle ambizioni di questo libro basta dare un’occhiata al sommario del quinto capitolo, che suona così: «Che cosa hanno in comune Stalin, la Rivoluzione del Neolitico e le città-stato della civilità Maya; e perché l’attuale crescita economica della Cina non può durare». Il libro fornisce un ventaglio di esempi, accuratamente documentati, che copre tutto l’arco della storia umana. Prendiamone alcuni, partendo dalle domande poste da Acemoglu e Robinson.
Perché l’industrializzazione compì i primi passi in Gran Bretagna e non altrove? Secondo i due autori la data chiave è il 1688, quando una dura lotta tra gli Stuart e il Parlamento (che rappresentava i proprietari terrieri e la borghesia nascente) finì con l’espulsione di Giacomo II e l’ascesa al trono di Guglielmo d’Orange. Il nuovo monarca firmò la Dichiarazione di diritti (Bill of Rights), accettando il ridimensionamento dei propri poteri. Da quello scontro (passato alla storia come la Rivoluzione Gloriosa) partì un circolo virtuoso di riforme che portarono a “includere” settori sempre più ampi della popolazione. Quella “inclusione”, con tutte le garanzie costituzionali che rapidamente vennero conquistate (fino al suffragio universale), spiega perché la rivoluzione industriale partì proprio in Inghilterra: la nuova borghesia nascente sapeva che avrebbe potuto godere dei profitti del proprio lavoro.
Perché il Messico è più povero degli Stati Uniti? Perché quelle due aree geografiche, nell’era della colonizzazione, ebbero destini diversi. In Messico, dopo la caduta dell’impero atzeco (1521), gli spagnoli imposero odiose tasse alla popolazione locale, che venne ridotta in schiavitù. Così ai locali fu impedito di trarre beneficio dal loro lavoro, mentre gli spagnoli si abituarono ad arricchirsi del lavoro degli altri. Negli Stati Uniti questa strada non fu percorribile. I tentativi di imporre un sistema feudale alle tribù locali (e poi ai coloni) si infranse contro la vastità del territorio: se si cercava di imporre regole troppo stringenti a un gruppo di persone, questo si spostava da un’altra parte. Rapidamente i coloni pretesero di avere voce in capitolo nella gestione di quelle terre, e di poter godere dei frutti del loro lavoro. I colonizzatori inglesi dovettero abbozzare.
In Messico si svilupparono istituzioni che sostenevano un’economia schiavista (estrattiva), negli Stati Uniti un’economia da uomini liberi (inclusiva).
Anche il successo e il declino dell’antica Roma vengono spiegati utilizzando questo schema. La potenza e la ricchezza di Roma crebbero finché le istituzioni repubblicane consentirono un’ampia partecipazione dei cittadini e l’inclusione di molti degli stranieri che accorrevano nella Città eterna. Quando l’avvento dell’Impero restrinse tali diritti, cominciò il declino. La Repubblica “inclusiva” si trasformò nell’Impero “estrattivo”, e la società romana andò incontro alla decadenza. Uno schema analogo, accuratamente documentato, viene proposto per l’ascesa e il declino di Venezia.
Applicata al comunismo sovietico, la teoria di Acemoglu e Robinson funziona così. L’URSS registrò una sostenuta crescita economica, alla metà del secolo scorso, quando riuscì a trasferire imponenti risorse da un’agricoltura improduttiva all’industria nascente. Il rapido balzo in avanti del Pil fu reso possibile dalla tragedia di un’intera generazione di contadini. Ma si trattava di una fiammata destinata a spegnersi, perché una crescita a lungo termine deve essere alimentata da una continua innovazione, cioè da un’incessante sostituzione del vecchio con il nuovo: il processo che Schumpeter battezzò “distruzione creativa”. Ma il potere politico non ama la distruzione, in particolare in quei sistemi dove il lavoro individuale non è libero di perseguire il profitto individuale. Fu proprio l’incapacità a innovare (e a consentire la distruzione creativa) che provocò la stagnazione e il collasso della società sovietica.
La società cinese seguirà la stessa parabola discendente? Acemoglu e Robinson ritengono di sì, a meno che Pechino non si decida a varare drastiche riforme istituzionali. Negli ultimi decenni, dopo il disastro maoista, il partito comunista è stato in grado di monopolizzare il potere e di promuovere una crescita partendo da un livello molto basso, ma questa crescita non è sostenibile. Acemoglu si domanda se sia possibile che un giovane imprenditore cinese osi fare concorrenza a un’impresa sostenuta dalle banche pubbliche. La risposta è negativa: impossibile. Quel giovane sarebbe dichiarato nemico dello stato. «D’altra parte, se la Cina non opera la transizione verso un’economia basata sulla distruzione creativa, non ci sarà crescita a lungo termine», dice Acemoglu. La crescita dell’India, che ha istituzioni più “inclusive” e democratiche, è destinata a durare ben più a lungo di quella cinese. La Cina e l’Unione Sovietica dimostrano che anche le dittature possono ottenere buoni risultati economici per decenni. Ma alla lunga i fondamentali prevalgono sempre.
Negli ultimi capitoli del libro Acemoglu e Robinson suonano il campanello d’allarme. I paesi occidentali hanno creato economie floride perché si sono dotati di istituzioni inclusive. Ma devono impedire che alcune potenti élites acquisiscano eccessivo potere. Se le élites diventano dominanti, possono condizionare le istituzioni e determinare il declino dell’economia. Le èlites odiano la distruzione creativa. Preferiscono che le cose restino come sono perché è proprio sullo status quo che fondano il loro dominio e i loro privilegi.
Di quali élites parlano Acemoglu e Robinson? Per esempio di quella finanziaria. L’eccessiva crescita del settore finanziario, negli ultimi decenni, può essere un elemento di debolezza del sistema occidentale. E anche l’aumento dell’ineguaglianza è un elemento di debolezza, perché un’abnorme diseguaglianza economica si trasforma in diseguaglianza politica. Se la campagna elettorale di qualcuno dipende dai finanziamenti di poche persone molto ricche, il potere politico che ne deriva difenderà gli interessi di pochi.
Le istituzioni possono diventare oppressive se il potere politico governa in nome di lobbies e difende lo status quo. La politica non ama la distruzione. Ma non si può investire nel futuro senza disinvestire dal passato.
Il messaggio di Agemoglu e Robinson, ridotto all’osso, è che alla lunga l’economia funziona solo se funziona la politica. Per questo in Italia, dove la politica si è da tempo inceppata e il potere di molte lobby resta inalterato, anche l’economia va a picco.
a cura di linkiesta.it

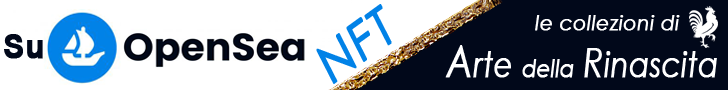































Facebook
Twitter
YouTube
RSS